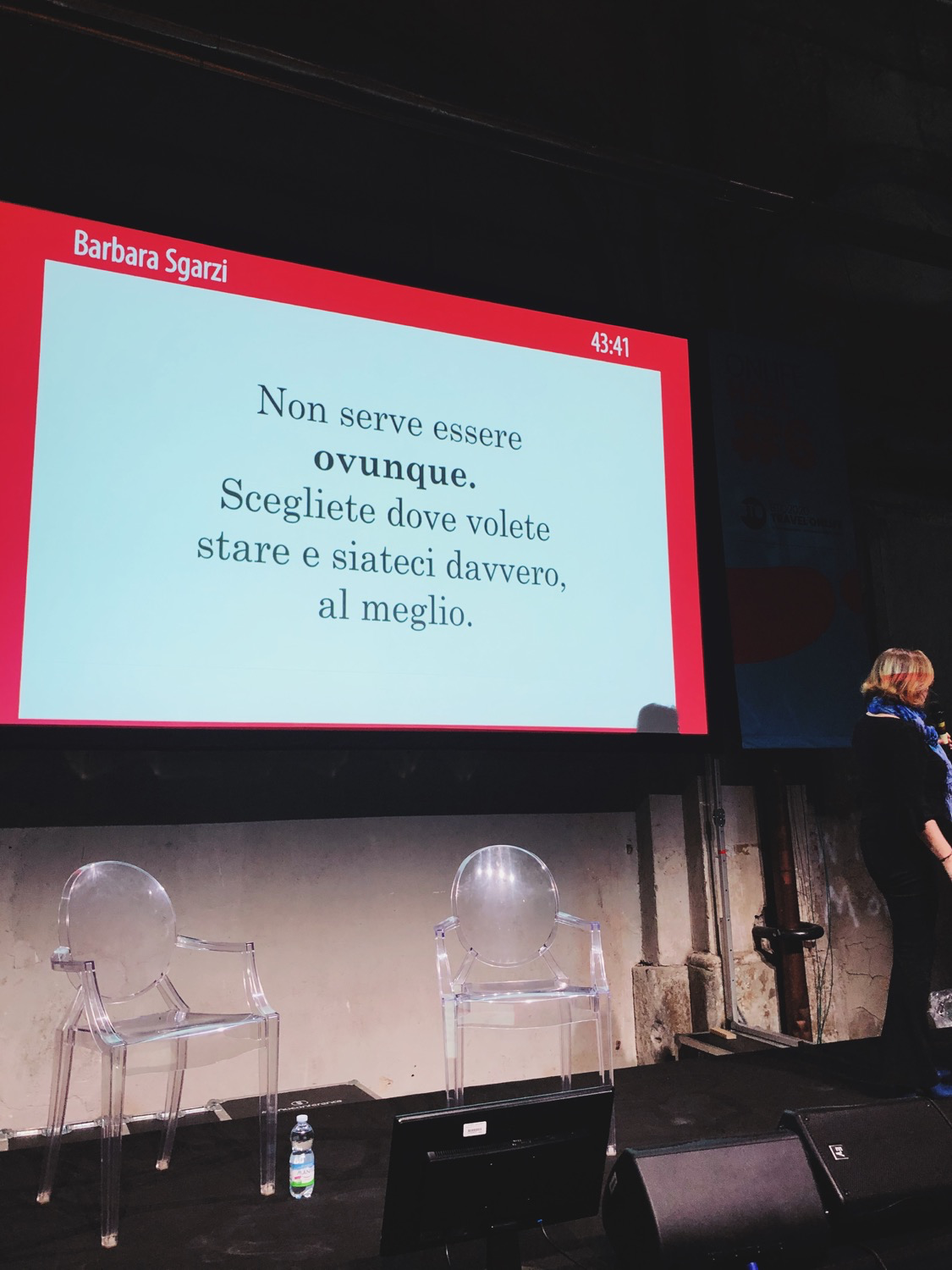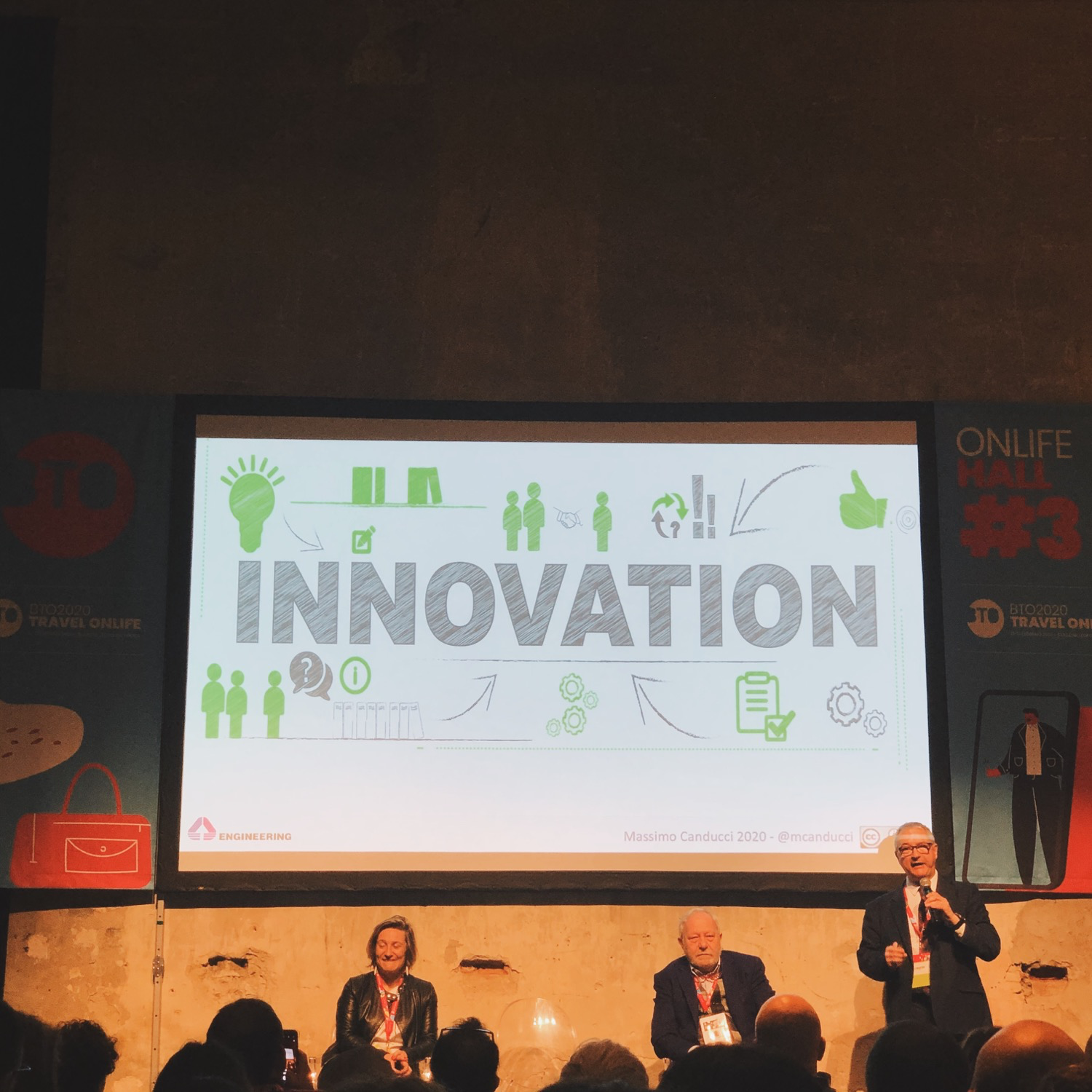La cosa più difficile, di quando scrivo, è trovare un titolo. Mi sale l’ansia che possa risultare piacione o fuorviante, come d’altronde mi mette ansia qualsiasi cosa fatta da me. Ma che dico, qualsiasi cosa punto. Stavolta, però, Dalla Russia con amore è la descrizione giusta per una giornata passata a scoprire un sottobosco di bellezze dell’Est nascoste nella capitale. Che scritto così sembra quel tour che si faceva da giovani, soprattutto se si era maschi, tra goliardia e curiosità.
Invece il mio era un goffo tentativo di dire che a Roma si può avere un assaggio di Europa dell’Est se si conosce dove andare.
O se si conoscono delle ottime guide turistiche.
Pain De Route o il pan di via
Direi che possiamo saltare i preliminari e passare subito al sodo, come sono arrivata a conoscere una visita guidata come questa.
Tutto parte dal recente periodo in cui siamo rimasti chiusi in casa a sognare le passeggiate intorno al palazzo come se fossero mete esotiche. Attraverso una delle persone più belle che abbia avuto l’onore di conoscere ultimamente (ciao Vale, questa è per te), vengo a sapere che c’è una ragazza che organizza dei tour virtuali in zone “inusuali”.
Mi scappa una premessa: io ho dei problemi a staccarmi dall’adolescenza, nel senso che certi atteggiamenti che ho tutt’ora mi sembrano un retaggio di quell’età che non rimpiango nella maniera più assoluta ma che allo stesso tempo non voglio mollare. Per esempio l’insofferenza verso tutto ciò che è troppo sovraesposto, a quindici anni si rifiutavano le cose troppo gettonate per il bisogno di distinguersi, a quaranta mi succede per non so quale motivo. Sicuramente non per distinguermi, da cosa se sto vivendo quasi come un’eremita che limita i contatti al minimo indispensabile per non impazzire e parlare con la friggitrice ad aria?
La sto facendo lunga, mi rendo conto. Quando ho sentito nominare questa ragazza e il suo lavoro fuori dai soliti quattro che imperversano sui social, ho subito provato un moto di simpatia. Lei è Eleonora e ha un sito che si chiama Pain de Route, che sta ad indicare il pan di via elfico di Il Signore Degli Anelli. Io, che non subisco per niente il fascino della saga di Tolkien, prenoto subito con lei un tour virtuale a Tbilisi (Georgia).
Eleonora gestisce mille e una attività, tra cui l’organizzazione di viaggi nei paesi dell’Est, una destinazione che non sento spesso citare come meta preferita. Il tour a Tbilisi è stato eccezionale, nonostante tutte le limitazioni date da un evento virtuale.

Rituali scaramantici pre-intervento
A ottobre scopro che Eleonora, insieme ad Alessandra di Vie di Fuga, organizza un tour proprio a Roma per far scoprire i luoghi russi della città. Sempre a ottobre mi opero di fibromi all’utero e siccome so essere anche melodrammatica, sono stata contenta di essere riuscita a fare questa esperienza pochissimi giorni prima dell’intervento.
Eleonora dal vivo risulta come mi era sembrata online: preparata, appassionata, con uno dei sorrisi più aperti e accoglienti mai visti. Forse la mia opinione su di lei è filtrata dalla stima che ho, ma ho pensato che di Eleonora si capisce subito che ha visto situazioni e luoghi molto differenti dalla nostra tutto sommato confortevole realtà.
Alessandra mi ha fatto una altrettanto bella impressione: anche lei preparata, coinvolgente nelle spiegazioni, divertente. Riesce a dare le informazioni in modo tale da farmi chiedere perché la mia professoressa di storia non fosse così. Mi sarei annoiata di meno e avrei imparato molto di più.

Prossima fermata: Basilica di San Clemente
Il tour inizia per me e il Dottore quasi a ridosso della prima visita a causa della lunga attesa per la visita anestesiologica che avevo la mattina. Quattro imprecazioni e una secchiata di sudore dopo, arriviamo sul luogo dell’appuntamento.
Si comincia dalla basilica di San Clemente, una chiesa che chiamano “la lasagna” perché si presenta su più strati di epoche diverse. Quello che non sapevamo, tra le tante spiegazioni che ci vengono fornite, è che questo luogo ha un particolare interesse per i popoli slavi in quanto qui sono custodite le reliquie di San Cirillo.

Io non sono religiosa, ma le storie, se ben raccontate, mi piacciono tutte e questa racconta di due fratelli (Cirillo e Metodio) che abitavano in quella che oggi conosciamo come Salonicco, in Grecia. A quei tempi la città poteva contare su una consistente presenza slava, che permise ai due fratelli di imparare quella lingua. La cosa tornò utile quando Cirillo e Metodio iniziarono l’evangelizzazione della Pannonia e della Moravia, ma c’era di più. I due presero talmente a cuore la questione della diffusione del Verbo, che inventarono l’alfabeto glagolitico, ancora oggi usato in Croazia e “padre” di quello che viene conosciuto come cirillico.
Questo e il fatto che si erano impegnati a riportare le reliquie di San Clemente a Roma, permise a Cirillo di essere accolto, alla sua morte, nella stessa basilica, che quindi è diventata un posto caro anche alla tradizione ortodossa.

Le rocambolesche morti dei santi
Un’altra delle cose più affascinanti, per me che sono appassionata di trasmissioni sui serial killer, è stata ascoltare le terribili e anche un po’ rocambolesche morti dei santi. I santi, infatti, prima di diventarlo devono subire morti atroci e possibilmente non tirare le cuoia prima di aver affrontato più di un tentativo di assassinio. San Clemente, per esempio, è stato gettato in mare con un’ancora a lui legata perché i romani erano persone previdenti. La mia preferita, però, rimane Santa Caterina, la martire di Alessandria. Racconta la storia che durante alcuni festeggiamenti pagani, lei si rifiutò di prendervi parte perché, appunto, pagani. Lo fece con tale intelligenza e coerenza, che l’imperatore pensò che sarebbero serviti dei “capoccioni” di pari livello per convincerla a rinnegare la sua fede e le inviò un gruppo di filosofi.
I filosofi non solo non la convinsero, ma si convertirono alla sua religione. L’imperatore allora, dotato di grande pazienza, le concesse il perdono se si fosse concessa a lui. Ma quella era santa, mica scema e rifiutò. Per questo fu imprigionata senza acqua né cibo.
Il digiuno, però, su di lei fece l’effetto della maschera di Lancome che la mia amica Tamara assicura restituire una pelle da Bella Addormentata. L’imperatore gioca la carta imperatrice, pensando che magari tra donne avrebbero parlato degli effetti del digiuno sulla pelle, ma non solo la moglie non riportò Caterina sulla retta via, ma venne a sua volta convertita.
A quel punto uno avrebbe rinunciato, ma l’imperatore non era uno e quindi condannò la ragazza alla tortura della ruota dentata, la quale invece che martoriare il corpo di Caterina, si bloccò. Per caso qualcuno ebbe come un sentore che la ragazza avesse una protezione di un certo livello? Non l’imperatore, comunque, che la fece decapitare. Tutto si può dire ma non che non fosse un uomo insistente.

Nessuno mette San Pietro in un angolo
A proposito di Santa Caterina, una delle tappe del tour è proprio la Chiesa di Santa Caterina Martire.
Come tante altre persone che abitano a Roma, conosco la città ma ci sono ancora diversi posti da scoprire. Per esempio una chiesa ortodossa che ricorda gli edifici del Cremlino alle spalle della ben più nota Basilica di San Pietro. Invece in un tripudio di bianco, oro e verde si presenta davanti a noi questa struttura che sa un po’ di Disneyland e un po’ di Piazza Rossa.
Fortuna vuole che in quel momento fosse in atto una liturgia.
Se poi si ha un po’ di fortuna e si riceve il consiglio giusto, si possono vedere le due chiese, magari al tramonto, da una prospettiva maestosa.
La parte divertente del racconto su questo edificio è che quando si decise di costruirlo, si presentava il problema che sarebbe risultato più alto della Basilica di San Pietro. Eresia! Nessuno mette San Pietro in un angolo e quindi bisognò optare per uno sbancamento del colle su cui si sarebbe eretta Santa Caterina, così da renderla meno vistosa. Insomma quella sottile rivalità tra Chiesa occidentale e quella orientale.

Arrivare a scoprire questa chiesa non è così banale, richiede un lungo tragitto con l’autobus e mi sembra che si siano accertati di non darle troppa visibilità altrimenti San Pietro ci rimaneva male.
Merita però la visita, da continuare lungo la Passeggiata del Gelsomino, un percorso intorno al Cupolone ricavato dallo spazio che prima era occupato da uno dei binari della ferrovia del Vaticano. Perché il Vaticano ha una ferrovia? Non diciamo sciocchezze, ovvio, è il Vaticano.
La gastronomia slava
Il nostro tour prevede ancora due soste. La prima è in una libreria di cultura russa, il Punto Editoriale, dove la coppia che l’ha aperta ci spiega le ragioni dietro alla scelta di avere un negozio a Roma rivolto a un segmento così specifico e ci lascia curiosare tra i titoli e le edizioni tanto incomprensibili, quanto affascinanti.

La conclusione degna della giornata è mangereccia. Ci fermiamo ad assaggiare dei prodotti tipici al Mix Markt di Roma Termini. Assaggiamo una bevanda alla betulla e il Kvass, una birra russa che sa di pane. Mangiamo cetriolini all’aneto e uova di salmone sul pane nero. La gastronomia slava ci convince talmente tanto che entriamo nel negozio a fare rifornimento. Noi in particolare ci portiamo a casa diversi prodotti, tra cui una crema di zucchine che crea dipendenza.

Un’altra porzione di realtà
Ho partecipato a questo tour per motivi già scritti, volevo andare in sala operatoria con un bel ricordo alle spalle, tante volte fossi rientrata in quella casistica esigua di chi non ne esce più.
Non solo non sono morta, ma ho anche fatto un’esperienza bellissima da tanti punti di vista. L’organizzazione di Eleonora e Alessandra è stata impeccabile, ho scoperto un’altra faccia della mia città, ho abbracciato persone che non avevo mai incontrato dal vivo e altre che non vedevo da un po’, ho riso tanto, ho mangiato e ho delle nuove foto sul cellulare.
Soprattutto ho capito che uno dei modi per non cadere nella rete della connessione costante e del ristagno nel presente, è cercare un’altra porzione di realtà. Diversa, insolita, poco conosciuta ma che possa riempire veramente la testa di sensazioni belle e liberarla dalle zavorre mentali.
Riempitevi di bellezza
Riempitevi di bellezza, se non in prima persona magari scegliendo un altro dei miei articoli e provando a partire con la testa.
Se invece avete bisogno mettere in moto tutto, Vie di Fuga per Natale ha pensato a dei buoni regalo per partecipare ai loro tour. Invece che ridurvi all’ultimo a comprare l’ennesimo oggetto che verrà buttato alla prima occasione, questa è un’alternativa migliore.